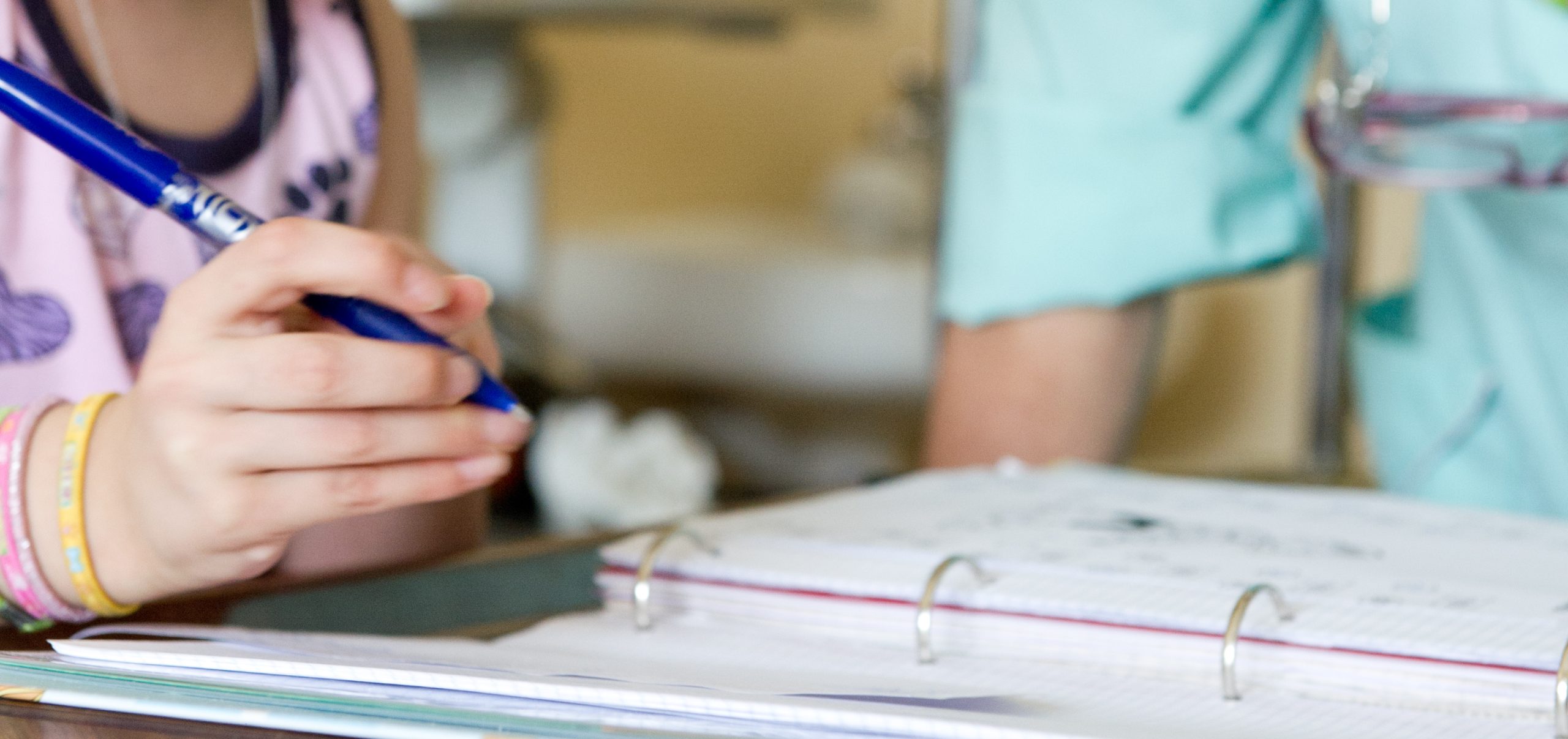Come facevo spesso, stavo leggendo al mio bambino una delle fiabe di Calvino, la bimba nel lettino accanto, che seguiva sempre con interesse, questa volta non ascoltava. “Perché la bambina è voltata contro il muro? cosa c’è?” chiedo alla mamma seduta accanto a me nel day hospital. Tante cose potevano esserci certo ma quello che mi ha confidato la mamma non me lo sarei mai aspettato. “Sa, la maestra le ha detto: – Che vieni a fare a scuola, tanto…” Era, credo, il 1983 e io, mamma e insegnante, ho scolpito quelle parole nel cuore. Erano parole che non potevano essere frutto di cattiveria, non era possibile, certamente di insensibilità ma, prima ancora, di ignoranza. Sì, perché allora non era conoscenza comune il fatto che i bambini, se si ammalano di tumore, possono guarire. In effetti non erano trascorsi molti anni dall’introduzione della chemioterapia e sia le cure che i risultati delle terapie non erano paragonabili a quelli attuali. In tutto l’ospedale c’era un maestro.
Anche lui forse aveva lo stesso pensiero, passava qualche volta e fuggiva via. Il mio bambino si è ammalato al secondo mese della prima elementare, le terapie sono durate tre anni, tre anni senza scuola, a quell’età, sarebbero stati disastrosi. Finiti i primi pesantissimi cicli, il professore Madon mi ha detto: “E ora tornate a scuola, tutti e due”. Era ormai primavera. La scuola di mio figlio non ha mai detto no, non l’ha mai cancellato dal registro (succedeva anche quello), i compagni, che stavano appena imparando a scrivere, gli mandavano i loro disegni. Gli insegnanti gli mandavano i compiti e lui faceva del suo meglio.
Dieci anni dopo decido di entrare in UGI e con me un’altra mamma, anche lei un’insegnante, Pia Rosatelli e abbiamo un progetto in testa: aiutare i ragazzi ammalati a non perdere la scuola. Il perché lo ha spiegato molto chiaramente nella sua intervista. Ho avuto la fortuna di aver vissuto molte esperienze che mi hanno aiutato ad immaginare un tipo di scuola diversa, meno rigida, capace di andare incontro ai bisogni degli alunni. Solo per fare un esempio in un ospedale di Marsiglia ho visto portare in aula studio i ragazzi anche allettati, anche stranieri, era il 1992. Più semplicemente, ad Amsterdam, la Scuola Internazionale organizzava l’insegnamento in modo da formare gruppi di studenti omogenei per adattare i programmi a ragazzi che arrivavano da tutto il mondo, con lingue, esperienze e programmi diversi alle spalle, integrando le lacune con insegnamenti particolari. Ricordo benissimo quello che abbiamo pensato in quel lontano 1993: l’obbligo scolastico è un obbligo per gli studenti e le famiglie, certo, ma anche la Scuola è obbligata ad erogare un servizio nel modo più consono alla situazione degli alunni.
Con quell’idea in testa, assicurato il consenso dell’ospedale e forte dell’appoggio di tutta l’UGI, sono andata in quello che allora si chiamava Provveditorato agli Studi per esigere quello che spettava ai ragazzi delle medie in terapia oncologica, infatti non si era mai presa prima in considerazione la scuola media che pure, appunto, è parte dell’obbligo scolastico. Il provveditore era in trasferimento ma la sua vice mi ha ascoltata, ha capito e approvato la nostra istanza e ha istituito la scuola media ospedaliera. A dirlo così sembra semplice ma la cosa ha richiesto da parte della Dottoressa il percorso di un complesso iter burocratico, particolare impegno personale e una assunzione di responsabilità di cui la ringrazieremo sempre. Non che sia filato tutto liscio, per esempio non è stato facile far capire a tutti fin da subito che non ci interessava solo la presenza degli insegnanti in ospedale quanto la scolarizzazione dei ragazzi ammalati. Potrebbero sembrare la stessa cosa ma non lo sono. Per noi era importante che gli insegnanti ospedalieri lavorassero di concerto con quelli della scuola di provenienza dell’alunno, che insieme tracciassero un curriculum, ponessero le basi perché il bambino/ragazzo potesse proseguire gli studi una volta guarito.
Ma quanto ottenuto non era sufficiente. Gli insegnanti dovevano sapere a cosa andavano incontro avendo nelle loro classi uno dei nostri bambini e ragazzi. Cosa fare? UGI organizza da sempre corsi di formazione per i volontari in collaborazione con l’Ospedale, perché non fare dei corsi di informazione/ formazione per gli insegnanti? I corsi sono partiti e qualche insegnante formato così, una volta in pensione, è diventato anche nostro volontario.
Negli anni il reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita ha definito diversamente il suo compito. I tumori degli adolescenti, in considerazione delle loro specifiche tipologie e dei bisogni degli ammalati di quella classe di età, dovevano essere curati in oncologia pediatrica, e quindi ragazzi fino a 18 anni all’esordio della malattia erano adesso curati in pediatria.
E la scuola? La scuola doveva adeguarsi, siamo nel 2000. Forte come sempre dell’appoggio incondizionato di tutta UGI comincio una nuova battaglia e ancora questa volta le Istituzioni ci sono accanto e rispondono alle nostre richieste. Concordato un progetto pilota con la preside dell’Istituto Regina Margherita, comincia la sperimentazione. Si crea un pull di cui fanno parte, oltre a noi, la Sovrintendenza scolastica regionale, il preside dell’Istituto Arduino di Torino e quello del Marro di Moncalieri, il Dipartimento di Oncoematologia pediatrica, la Divisione di Neuropsichiatria Infantile e il Servizio di Psicologia Clinica dell’O.I.R.M., qualche volta ha presenziato agli incontri Gianni Oliva, allora assessore all’istruzione della provincia di Torino. In un certo senso l’impresa è più facile: la scuola ospedaliera per l’età dell’obbligo si è ormai diffusa, si sono tenuti convegni sull’argomento, anche organizzati con la nostra collaborazione. Da un’altra parte però l’organizzazione è più complessa, le tipologie di Scuole secondarie di secondo grado sono moltissime, con materie a volte molto specifiche. Ma si poteva fare ed è stato fatto. Fino al giorno in cui ho assistito alla maturità di una nostra ragazza che, non potendo andare nella sua scuola, l’ha sostenuto a Casa UGI: è venuta da noi la commissione. Era solo la prima volta. Non ho parlato qui di come, dopo i progetti iniziali, la scuola ospedaliera si sia strutturata, siano nate le scuole polo, di come gli psicologi ospedalieri collaborino costantemente con gli insegnanti. Lascio il compito a chi può farlo meglio di me, infinitamente grata a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a concretizzare questo nostro progetto.
Voglio però ancora ricordare la nascita di UGIDUE, la realizzazione del Progetto Ponte per l’off therapy di cui il sostegno per il reinserimento scolastico fa parte. Siamo ormai negli anni 20 del 2000. Ma non finisce qui, forze nuove di UGI hanno ripreso gli incontri di informazione nelle scuole che tenevamo già negli anni novanta. Tutto è diverso, diversi sono soprattutto gli alunni a cui ci rivolgiamo ma lo scopo è lo stesso: creare un ambiente accogliente per i nostri bambini e ragazzi che si ammalano, perché nessuno si permetta neppure di pensare ad escluderli, e diffondere la conoscenza della malattia e della prevenzione portando avanti così una delle molte missioni di questa nostra Associazione. Siamo nel 2024.
LA BUONA SCOLARIZZAZIONE È IMPORTANTE PER TUTTI I GIOVANI, PER I GIOVANI GUARITI DA TUMORE PEDIATRICO LO È DI PIÙ.
E c’è un perché. Anche se sempre di più si diffonde la consapevolezza che un giovane guarito da tumore pediatrico è eguale a tutti gli altri, e la legge sull’oblio oncologico lo sancisce, ci sono casi in cui la malattia e le cure possono comunque lasciare dei problemi di salute. Proprio in quei casi un lavoro fisicamente impegnativo potrebbe non essere adatto per i nostri giovani e una scolarizzazione di qualità può aprire la strada a professioni diverse, che richiedono un impegno intellettuale più che fisico. Non dimentichiamo poi che la progressiva informatizzazione del mondo del lavoro richiede una preparazione diversa dal passato per cui rimarranno a disposizione di chi non è adeguatamente scolarizzato soltanto impieghi di bassissimo profilo socioeconomico.